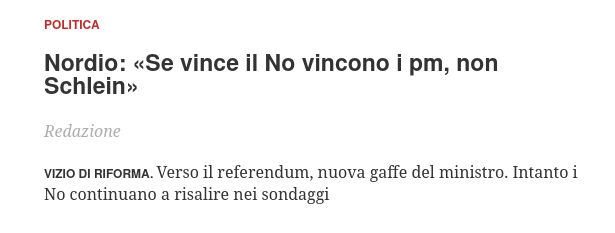APPUNTI ERETICI SUL REFERENDUM GIUSTIZIA
C’è un filo nero che unisce Washington a Roma. Non è diplomatico. È ideologico.
Negli Stati Uniti la giustizia è da sempre terreno di conquista. La Corte Suprema degli Stati Uniti è stata trasformata in una roccaforte politica: giudici selezionati per orientamento, confermati a colpi di maggioranza, sostenuti da reti organizzate. Non equilibrio, ma forza numerica. Sei contro tre. Una maggioranza che incide su aborto, diritti civili, poteri federali.
La politicizzazione non è un effetto collaterale. È il metodo. Il Presidente nomina, il Senato ratifica, i gruppi ideologici preparano le liste. I pubblici ministeri cambiano con l’amministrazione. Le priorità dell’accusa seguono l’agenda politica. La giustizia entra nella dinamica del consenso, si intreccia con la competizione elettorale, diventa strumento di indirizzo culturale.
Questo modello seduce una parte della destra europea. Seduce anche il governo guidato da Giorgia Meloni, che guarda al trumpismo come a un laboratorio riuscito di egemonia istituzionale. Da tempo si ripete che in Italia esisterebbe un “governo dei giudici”, una magistratura invasiva, un potere fuori controllo. La risposta proposta è nota: ridisegnare gli equilibri, ridurre l’autonomia, riportare la giustizia sotto un perimetro più vicino all’esecutivo.
Alterare quell’equilibrio non significa solo riformare procedure. Significa intervenire sul cuore della separazione dei poteri. La tentazione è chiara: conquistare le istituzioni che possono plasmare il futuro per decenni, anche oltre il ciclo elettorale.
La disputa sulla giustizia viene spesso raccontata come uno scontro tra garantisti e giustizialisti, tra chi difende lo Stato di diritto e chi lo vorrebbe piegare. Ma c’è una terza voce, rimossa dal racconto ufficiale: quella di chi non ha mai visto nella magistratura italiana un potere neutrale.
Nel dopoguerra, i tribunali non nascono in un vuoto. Molti uomini in toga arrivano direttamente dall’epoca fascista. Parte di quella macchina giudiziaria resta in piedi. Non è un dettaglio biografico: è una continuità strutturale.
Basta guardare a ciò che accade nelle campagne e nelle piazze. Braccianti e operai cadono sotto il fuoco delle forze dell’ordine. Le responsabilità si sfilacciano nelle aule di giustizia. I procedimenti si trascinano, le imputazioni si alleggeriscono, le assoluzioni si accumulano. Le inchieste, una dopo l’altra, si chiudono senza colpevoli.
La rottura promessa dalla nuova Repubblica frena anche sulla soglia dei tribunali. Poi arriva la stagione delle bombe. Piazza Fontana, Piazza della Loggia, l’Italicus. La cosiddetta strategia della tensione attraversa il Paese e una parte della magistratura insegue piste che colpiscono a sinistra. Giuseppe Pinelli precipita da una finestra della questura di Milano. Nessun colpevole. Pietro Valpreda viene indicato come mostro mediatico prima ancora che imputato. Anni dopo, le sentenze smontano le accuse. Ma intanto le vite sono state travolte.
A metà anni Settanta, l’ondata repressiva investe il dissenso politico. Nel 1977 la repressione accompagna lo scontro di piazza. Arresti di massa, custodie cautelari interminabili, costruzioni accusatorie fragili. Le radio di movimento vengono chiuse. Il confine tra ordine pubblico e conflitto sociale si fa labile. A Roma si parla di “porto delle nebbie” per indicare un tribunale dove le inchieste scomode evaporano. Figure come il giudice Alibrandi - fascista dichiarato - assicurano impunità indecenti. Magistrati che si occupano di neofascismo come Occorsio o Amato vengono lasciati soli.
Il 7 aprile 1979 scatta l’operazione guidata dal magistrato Pietro Calogero: l’idea di un’unica regia politico-militare dietro l’Autonomia operaia e le Brigate Rosse diventa un teorema giudiziario. Le aule si trasformano in luoghi di regolamento politico. Alla fine: 60.000 militanti indagati e 25.000 arrestati. Carceri speciali.
Questo è il curriculum che, chi scrive, non dimentica. Non una deviazione occasionale, ma una traiettoria in cui la magistratura ha agito come ingranaggio dell’ordine costituito, non come suo correttivo.
Oggi la destra attacca le toghe in nome del primato della politica. Una parte del fronte opposto le difende in nome della legalità. Ma per chi ha memoria di quelle stagioni, la questione è più aspra: lo Stato di diritto non è mai stato un terreno neutro. Troppo spesso ha colpito in basso e protetto in alto. È stato un campo di forze, attraversato da rapporti di potere, da continuità opache. Una storia che pesa ancora, ogni volta che si invoca la neutralità delle toghe come verità indiscutibile.
Il fine di questo articolo non si colloca nel dibattito pubblico - già abbastanza logoro - sul referendum di marzo. Anche perché il fronte del No non è affatto immune da pulsioni giustizialiste: la tentazione della manetta, sempre e comunque, attraversa schieramenti che si proclamano opposti.
Qui si tratta di rimettere in fila i fatti, di restituire spessore storico a una discussione che troppo spesso si consuma nell’immediato. Prima delle parole d’ordine, prima delle campagne, c’è una storia. E quella storia pesa ancora.
Andrò a votare No. Non per difendere l’ordine esistente, non per arruolarmi sotto la bandiera della magistratura. Sarà un No solo politico, un No a questo governo di estrema destra e alla sua idea di concentrazione del potere.
Non mi riconosco in alcun apparato giudiziario di questo Stato, segnato da continuità storiche mai del tutto recise con il fascismo e reti di potere massoniche. Fingere che tutto sia neutro, che la toga sia stata sempre impermeabile a queste influenze, significa riscrivere la storia.
Il mio No è una scelta contro chi oggi governa. Una risposta politica a un’offensiva politica.
Alfredo Facchini