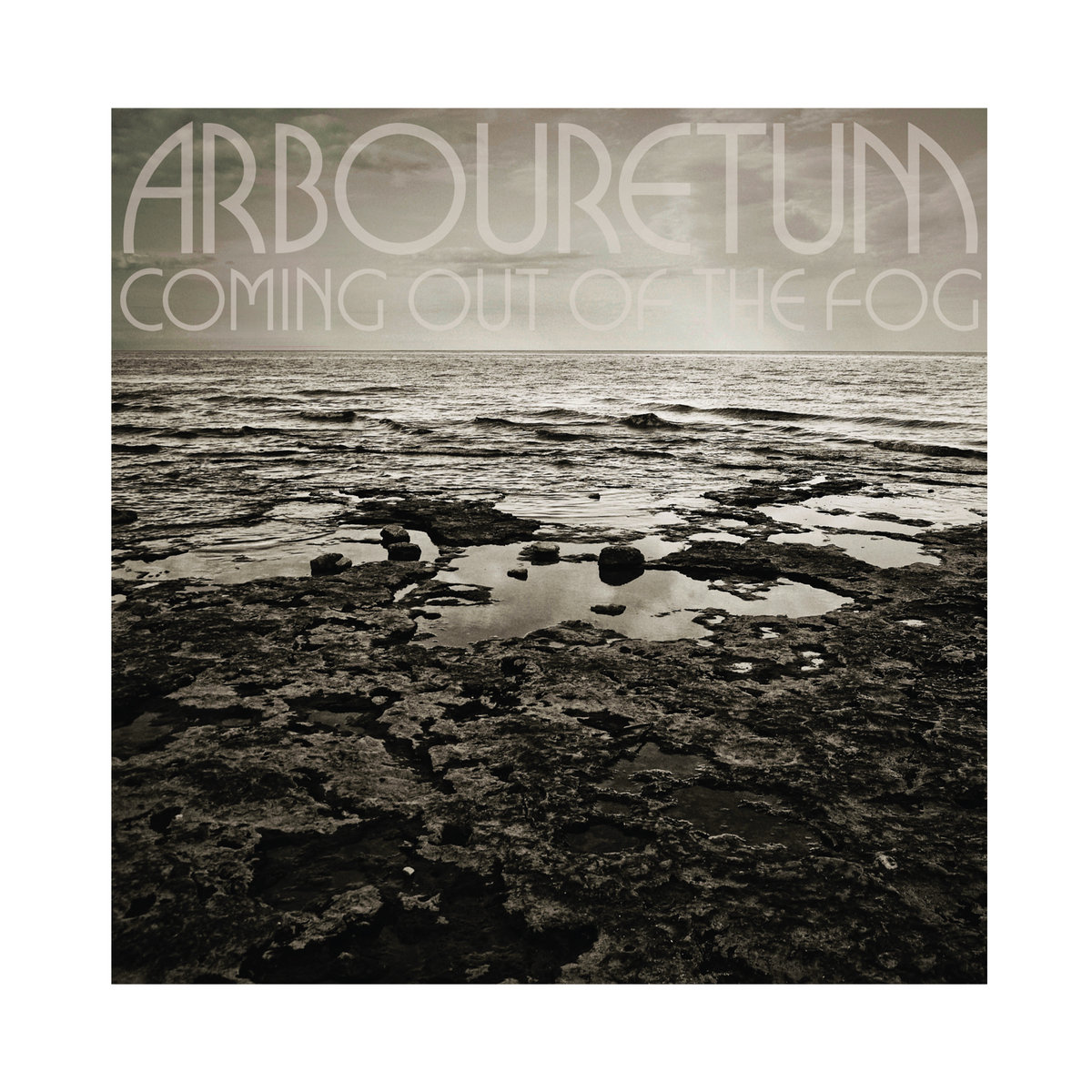QOELET - Capitolo 4
L’oppressione1Tornai poi a considerare tutte le oppressioni che si fanno sotto il sole. Ecco le lacrime degli oppressi e non c'è chi li consoli; dalla parte dei loro oppressori sta la violenza, ma non c'è chi li consoli. 2Allora ho proclamato felici i morti, ormai trapassati, più dei viventi che sono ancora in vita; 3ma più felice degli uni e degli altri chi ancora non esiste, e non ha visto le azioni malvagie che si fanno sotto il sole.
La fatica del lavoro4Ho osservato anche che ogni fatica e ogni successo ottenuto non sono che invidia dell'uno verso l'altro. Anche questo è vanità, un correre dietro al vento.5Lo stolto incrocia le sue braccia e divora la sua carne.6Meglio una manciata guadagnata con calma che due manciate con tormento e una corsa dietro al vento.
La solitudine7E tornai a considerare quest'altra vanità sotto il sole: 8il caso di chi è solo e non ha nessuno, né figlio né fratello. Eppure non smette mai di faticare, né il suo occhio è mai sazio di ricchezza: “Per chi mi affatico e mi privo dei beni?”. Anche questo è vanità e un'occupazione gravosa.9Meglio essere in due che uno solo, perché otterranno migliore compenso per la loro fatica. 10Infatti, se cadono, l'uno rialza l'altro. Guai invece a chi è solo: se cade, non ha nessuno che lo rialzi. 11Inoltre, se si dorme in due, si sta caldi; ma uno solo come fa a riscaldarsi? 12Se uno è aggredito, in due possono resistere: una corda a tre capi non si rompe tanto presto.
Il potere13Meglio un giovane povero ma accorto, che un re vecchio e stolto, che non sa più accettare consigli.14Il giovane infatti può uscire di prigione ed essere fatto re, anche se, mentre quello regnava, era nato povero. 15Ho visto tutti i viventi che si muovono sotto il sole stare con quel giovane, che era subentrato al re. 16Era una folla immensa quella che gli stava davanti. Ma coloro che verranno dopo non si rallegreranno neppure di lui. Anche questo è vanità, un correre dietro al vento.
Fedeltà alle promesse fatte a Dio17Bada ai tuoi passi quando ti rechi alla casa di Dio. Avvicìnati per ascoltare piuttosto che offrire sacrifici, come fanno gli stolti, i quali non sanno di fare del male.
_________________Note
4,5 divora la sua carne: cioè si consuma nell’ozio, sciupa la propria esistenza.
4,13-16 La sapienza tradizionale vedeva nel re e nell’anziano i simboli della saggezza; l’esperienza invece dimostra a volte il contrario.
=●=●=●=●=●=●=●=●=●=●=●=
Approfondimenti
vv. 1-3. Qoelet torna a puntare l'attenzione sulla malvagità umana: vede le lacrime degli oppressi, constata l'assenza di un consolatore e ribadisce con insistenza tale assenza, in contrasto con la fiducia nel giudizio divino che proponeva in 3,17. Allo stesso modo, se in 3,18 trovava un senso, pur non molto soddisfacente, al libero corso dell'iniquità, in 4,2-3 Qoelet si lascia ferire dall'agire malvagio dell'uomo fino a provare fastidio per la vita e a desiderare di non essere mai nato. Nel Talmud si afferma che le scuole di Hillel e di Shammai, grandi maestri dell'epoca erodiana, discussero per due anni e mezzo se per l'uomo fosse stato meglio essere creato oppure non esserlo. Conclusero che sarebbe stato meglio che non fosse creato, ma, ora che lo era, doveva esaminare le sue azioni e vivere un'esistenza virtuosa (cfr. ’Eruvin 13b, cit. in Scherman-Zlotowitz, 100).
vv. 4-6. Qoelet scopre una radice cattiva anche nelle azioni migliori per abilità e per successo; è l'invidia che spinge ad agire, molto più che l'utilità. Tuttavia ciascuno sente l'esigenza di giustificare il proprio comportamento, e i proverbi esistono anche per questo scopo. L'autore ne cita due, diametralmente opposti, uno che biasima la pigrizia e uno che la preferisce alla fatica. Di sfuggita, il commento: «è un inseguire il vento»; «parole al vento», diremmo noi.
vv. 7-8. Assurdità la fatica mossa dall'invidia, fatica inutile cercare nella sapienza tradizionale la giustificazione delle proprie scelte, assurdità la fatica di accumulare tesori per la propria solitudine, impedendosi di godere il presente. Poiché la vita è comunque fatica, la solitudine, cioè l'assenza di qualcuno con cui e per cui faticare, rende la vita un pessimo affare. Inizia qui un gioco di linguaggio sui due significati di “uno” e “due”: prima “essere solo” / “essere in compagnia” (4,7-12), poi “essere prima” / “essere dopo” (4,13-16).
vv. 9-12. In antitesi all'assurdità della solitudine, ecco i vantaggi – piccoli invero, ma reali – della compagnia. Le esemplificazioni che seguono sono esperienze talmente elementari e ovvie che prendono immediatamente un valore simbolico molto forte. Considerando che il contesto è ancora sempre quello di una vita terribilmente assurda e intessuta di fatica senza alcun guadagno, non è difficile interpretare questi piccoli, banali e umanissimi gesti come simboli di quella realtà ben più vasta che è la solitudine spezzata. Ancora più notevole è che questi simboli si salvano dalla falce dell'universale assurdità, quasi a dire che, se un vero e proprio senso della vita non si può trovare, il non essere soli rende almeno più vivibile questa vita, e la compagnia è un fuoco che scalda il cuore e mette allegria.
vv. 13-16. Torna il tema di fondo del guadagno vanificato o illusorio, visto nella prospettiva della successione, o meglio di un colpo di stato, ennesima attività frenetica, inutile, assurda (ben parallela con l'altra fatica vana, quella dell'avaro in 4,8, con cui fa inclusione). È da notare che Qoelet capovolge degli assunti che nella tradizione sapienziale hanno quasi valore di dogmi: egli usa una forma classica della letteratura sapienziale (il detto «è meglio questo di quello») per dire che non sempre la saggezza è degli anziani, né si trova nei “posti” importanti. D'altra parte anche la saggezza per così dire “alternativa”, quella del giovane povero che riesce ad usurpare il trono e a conquistare un'immensa ricchezza, non è vera saggezza, perché non porta frutti al di là dell'immediato presente: è ben raro che chi è nato povero e si è arricchito all'improvviso sappia amministrarsi in modo oculato.
vv. 4,17-5,6. Nel passo 4,17- 5,6 lo stile cambia: non si tratta più di un soliloquio (cessano i verbi alla prima persona singolare) ma di consigli (verbi all'imperativo o allo iussivo). Il passo è diviso in due parti, 4,17-5,2 e 5,3-6: la prima si incentra sul parlare a Dio, la seconda specifica questo parlare nel senso di fare voti (e cosi si chiarisce nel v. 4 che cosa sia il sacrificio degli stolti del v. 4, 17). Entrambe le parti tendono a porre l'uomo nella giusta relazione con Dio, che è il rispetto, quello che con termine tecnico si definisce il «timor di Dio». Esso è motivato dalla trascendenza di Dio («Dio è in cielo e tu sulla terra»), il che non significa una lontananza indifferente (come dicono gli empi di Sal 10,4 e 94,7), ma una signoria onnipotente. E l'uomo non può cogliere la logica dell'agire divino, né influenzarla, benché essa lo domini e possa metterlo in pericolo. Tale senso religioso autentico è contrapposto a una falsa religiosità, fatta di sogni, assurdità e parole (5,6), che ha una matrice prettamente psicologica, poiché nasce da ansietà e logorrea. Qoelet non è né nichilista né agnostico, è soltanto uno che non tollera la verbosità di coloro che sono convinti di riuscire a imbrigliare la complessità del reale con le loro parole, e cosi usa lo scudiscio dello hebel per smentire ogni forma di apparente saggezza.
(cf. PAOLO PAPONE, Qoelet – in: La Bibbia Piemme, Casale Monferrato, 1995)