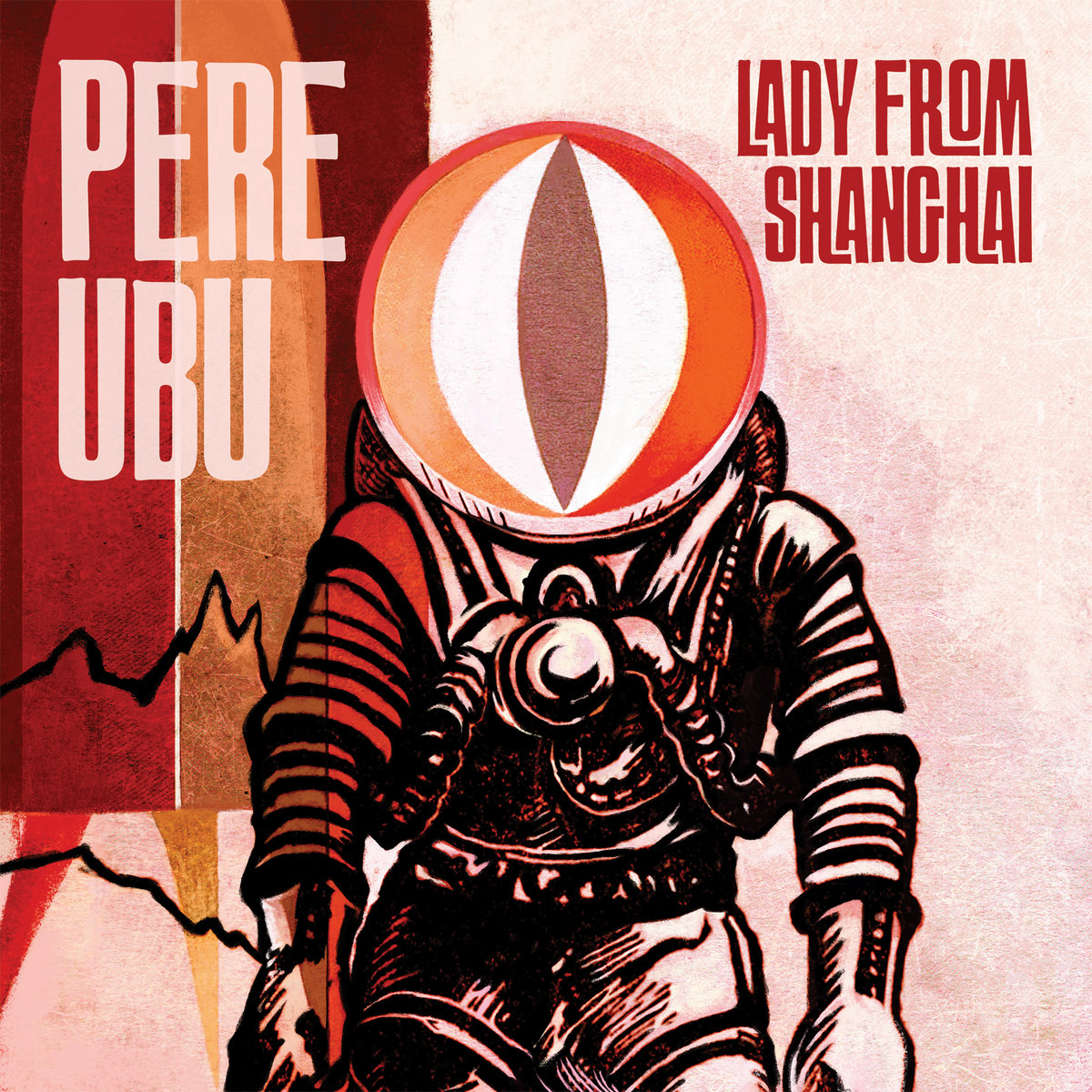CANTICO DEI CANTICI - Capitolo 2
1Io sono un narciso della pianura di Saron, un giglio delle valli.2Come un giglio fra i rovi, così l'amica mia tra le ragazze.3Come un melo tra gli alberi del bosco, così l'amato mio tra i giovani. Alla sua ombra desiderata mi siedo, è dolce il suo frutto al mio palato.4Mi ha introdotto nella cella del vino e il suo vessillo su di me è amore.5Sostenetemi con focacce d'uva passa, rinfrancatemi con mele, perché io sono malata d'amore.6La sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia.7Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, per le gazzelle o per le cerve dei campi: non destate, non scuotete dal sonno l'amore, finché non lo desideri.
SECONDO POEMA (2,8-3,5)
Lo sposo cerca la sposa8Una voce! L'amato mio! Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline.9L'amato mio somiglia a una gazzella o ad un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro; guarda dalla finestra, spia dalle inferriate.10Ora l'amato mio prende a dirmi: “Àlzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto!11Perché, ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata;12i fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna.13Il fico sta maturando i primi frutti e le viti in fiore spandono profumo. Àlzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto!14O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole”.
Intensità d’amore15Prendeteci le volpi, le volpi piccoline che devastano le vigne: le nostre vigne sono in fiore.16Il mio amato è mio e io sono sua; egli pascola fra i gigli.17Prima che spiri la brezza del giorno e si allunghino le ombre, ritorna, amato mio, simile a gazzella o a cerbiatto, sopra i monti degli aromi.
_________________Note
2,1 il nome della pianura costiera, che si estende dalla città di Giaffa al monte Carmelo. A questo nome è collegata l’idea di prosperità e abbondanza.
2,4 cella del vino: il luogo dove veniva fatto fermentare il vino.
2,12-14 Nella poesia biblica la tortora, con il suo canto, era considerata il simbolo dell’amore; la colomba il simbolo della fedeltà e della fecondità.
2,15-17 L’immagine delle piccole volpi che devastano le vigne può essere compresa come un’ombra minacciosa, attorno alla luce e alla bellezza dell’amore, che va difeso. Nel simbolismo biblico, la vigna è immagine della donna ed è anche il bene più prezioso che l’agricoltore possiede.
=●=●=●=●=●=●=●=●=●=●=●=
Approfondimenti
vv. 1,15-2,3. Segue dal capitolo precedente lo scambio tra lui (1,15; 2,1) e lei (1,16; 2,2). L'oasi di verde e di pace impresta così l'ultimo mutuo elogio, prima di consumare l'amore (2,4-6). L'amato è per lei «un narciso di Saron, un giglio delle valli» (2,1). Il narciso è un fiore delicato – ma dal profumo intenso – di quella fertilissima pianura di Saron sulla costa mediterranea della Palestina, emblema di tutte le pianure; il giglio dei campi è un fiore semplice, eppure dotato di una bellezza incomparabile (cfr. Mt 6,28-29; Lc 12,27). Lui riprende la seconda immagine per parlare di lei: non «un giglio dei campi», ma «un giglio tra i cardi» (2,2), un giglio miracolosamente spuntato in un campo di spine, perché lei è la donna più bella che esista, di una bellezza incomparabile. E lei risponde all'amato evocando l'immagine del melo (2,3a), un albero spesso presente nella poesia erotica: evoca qualcosa di fortemente desiderabile (2, 3b) perché capace di donare dolci e insieme forti sensazioni, e l'ombra della sua chioma è come un abbraccio di fecondità.
vv. 4-7. La «cella del vino» è la stanza dell'amore, spesso simboleggiato nel Ct con il vino (1,2.4; 4,10; 5,1; 7,10; 8,2); e l'insegna (il «vessillo» del v. 4b) della cella del vino non può essere che amore! I due amanti abbracciati consumano l'amore, con gesti (v. 6) che tutte le culture conoscono. La donna, «malata d'amore» (o – come traducono i LXX – «perforata da amore»), spossata dall'amplesso, chiede «focacce d'uva passa» (cfr. Os 3,1; Is 16,7 ecc.) e succo di «mele», considerati dagli orientali come un afrodisiaco e un sostegno vitaminico. E l'amato implora il coro invisibile delle figlie di Gerusalemme a non svegliare l'amata dal suo sopore amoroso (v. 7); ma potrebbe essere ancora lei a parlare, invitando a non disturbare l'amore (in ebraico, è femminile!), a rispettarne i tempi e i momenti, «a lasciare nella pace i due amanti assopiti l'uno nelle braccia dell'altra» (D. Garrone). L'appello chiama in causa «le gazzelle e le cerve», sacre in Oriente alla dea dell'amore Astarte, per la bellezza e la libertà dell'amore che esse simboleggiano.
vv. 8-17. Con il v. 8 ha inizio un nuovo canto. Dopo il primo poema (1,9-2,7), che costituisce in qualche modo l'ouverture e anche una specie di riassunto del Ct, il tema dell'amore sponsale si dispiega come un appuntamento primaverile. L'inverno è assenza; la primavera è presenza.
vv. 8-14. Una voce inconfondibile risveglia l'amata verso l'alba. Il diletto ha valicato monti e colline che lo separavano da lei, veloce e leggiadro come «un capriolo o un cerbiatto» (v. 9a), che apre sempre la marcia nei branchi dei cervi. La voce, grido dell'amato, appena egli si avvicina alla casa di lei e si mette ad occhieggiare dietro la finestra protetta dalla grata, diventa parola-appello personale all'incontro d'amore: «Alzati e vieni!» (v. 10). La bella stagione primaverile, brevissima ma intensa in Palesina, viene stupendamente descritta (vv. 11-13) con una notazione visiva (i fiori), uditiva (il canto degli umani in sintonia con il cinguettio degli uccelli) e persino olfattiva (la fragranza delle vigne in fiore e dei fichi primaticci). Ogni volta che trionfa l'amore – sembra dirci il Ct – passa l'inverno che tiene prigionieri della propria paura e del proprio esilio ed esplode la primavera della vita, come fosse il primo mattino del mondo. «Amica mia, mia bella, mia colomba» (v. 14). L'amata diventa ora, nell'invocazione di lui, la sua colomba: simbolo ben noto a molta letteratura d'amore ed espressivo della fedeltà della coppia, nonché di una grazia ricca di attenzioni e dimostrazioni d'affetto. E il nuovo simbolo sposta il sogno dalla casa alla roccia e alle sue fenditure, agli anfratti dei dirupi in cui le colombe selvatiche amano nidificare. Lo sposo implora «la sua colomba» di mostrargli il suo viso leggiadro e di fargli udire la sua voce soave, le propone un'intimità che abolisca separazione e segreti.
vv. 15-17. Il coro interrompe l'appello d'amore di lui, con un invito a creare una specie di difesa attorno alla vigna meravigliosa dell'amore. L'immagine della «vigna» per designare il corpo e la femminilità di lei era già presente in 1,6; ma qui si parla de «le nostre vigne» al plurale, come se il coro delle amiche si mettesse in sintonia già con la voce di lei (vv. 16-17). L'amore sponsale è sempre minacciato dalle «piccole volpi» golose dei grappoli d'uva in maturazione, contro le quali si organizzavano in Oriente turni di guardia notturni. L'amore, che è tutto vita-freschezza-floridezza-profumo come «una vigna in fiore», va difeso dai tanti predatori che ne vogliono fare scempio. Il canto si chiude (vv. 16-17) con un'altissima dichiarazione d'amore sulla bocca di lei: «Il mio diletto è per me e io per lui». Questa formula di mutua appartenenza, ripetuta anche in 6,3 e 7,1 e che in versione più distesa esprime nell'AT la relazione di alleanza tra Dio e Israele (cfr. Dt 26,17-18; Os 2,25; Ger 7,23; 11,4; Ez 34,30-31 ecc.), consacra i due sposi l'uno con l'altro, l'uno per l'altro, totalmente, sempre. Si tratta di un sospiro d'amore consumato, visto che nel v. 16b «lui pascola tra i gigli», con un'allusione all'intimità dei due amanti: in 4,5 «i gigli» alludono al corpo della ragazza in mezzo a cui, come due gazzelle, spuntano i seni. Il v. 17, uno dei più difficili del Ct, evoca con una forte carica di erotismo una notte piena d'amore. L'amata invita il suo diletto a visitare come un cerbiatto «i monti degli aromi», simbolo del corpo di lei, «prima che spiri la brezza del giorno e si allunghino le ombre».
(cf. VALERIO MANNUCCI, Cantico dei Cantici – in: La Bibbia Piemme, Casale Monferrato, 1995)