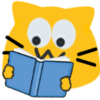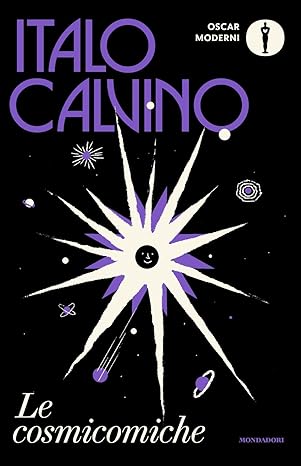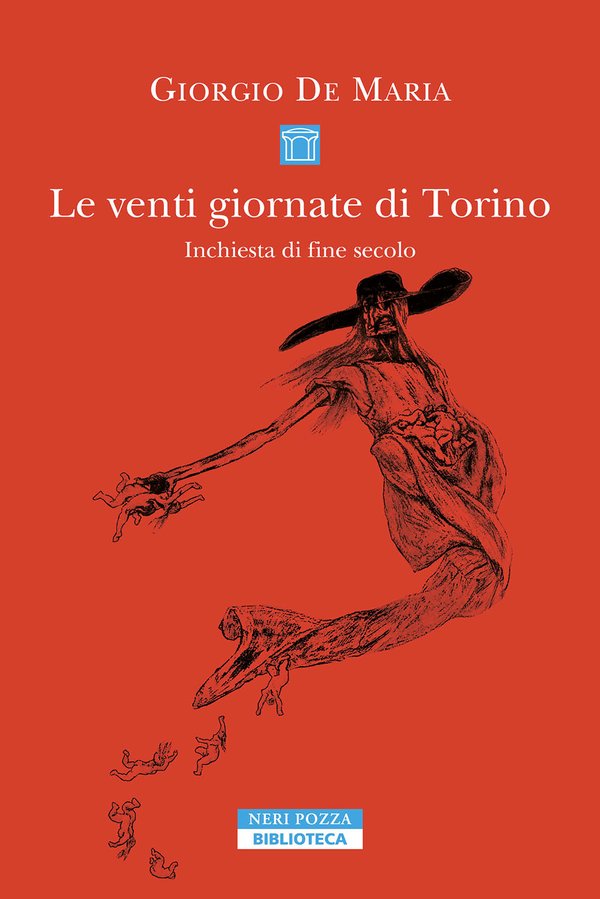Finita l’estate partiamo con la discussione de Le venti giornate di Torino di Giovanni De Maria.
Libro breve, di facile lettura, ma che rimane impresso, sia per (a mio avviso) l’ottima scrittura e ritmo sia per la sua piccola epopea letteraria: la prima edizione del 77 fu praticamente dimenticata ancor prima dell’uscita, per essere poi (ri)scoperta da un tizio australiano che lo tradusse in inglese, il libro ebbe successo ed un editore italiano lo ristampa come un caso letterario italiano all’estero…
Venendo al libro, beh, qualcuno lo ha accostato alle opere di Lovecraft e troppo lontano non è andato, c’è una sensazione opprimente per tutto il libro, un orrore sempre dietro l’angolo, di quello che ti fa stare inquieto, sempre sul chi vive, i 3 grandi temi che scandiscono il racconto, l’insonnia, la biblioteca, gli omicidi, sembrano molto distanti tra loro a livello “pratico” ma si fondono a livello percettivo.
La biblioteca di per se, ai fini della storia non ha a mio avviso una funzione rilevante, nel senso che, prendendo solo il discorso omicidi/insonnia il libro andrebbe serenamente avanti da se come “horror/noir soft”, ma l’aggiunta della biblioteca rende tutto più inquietante concorrendo a questa aria di incertezza, di essere osservati, di inquietudine.Parlando della biblioteca molti l’hanno vista come una profezia dei social network, ci può stare ma per me è una cosa più profonda, è riferito al voyeurismo ed esibizionismo, al voler far sapere di noi tutte le nefandezze, liberarci da tutti i nostri orridi segreti senza essere visti, ma soprattutto conoscere quelli degli altri, morbosamente. Va anche però vista come un’allegoria non troppo velata del controllo sui cittadini negli anni di piombo (il libro è pubblicato nel 77 e scritto l’anno prima se non erro), quando dei giovani ben vestiti e gentili, che volevano solo far diventare più amici i pochi torinesi rimasti dopo una siccità che ha rimandato tutti i meridionali alle proprie terre svuotando di fatto la città, fanno quasi più inquietudine degli omicidi.
Salto alla fine (e sotto spiego perché) dove nell’ultimo delirante capitolo il protagonista (che è bene ricordare essere totalmente senza nome) esortato a lasciare Torino dall’avvocato Segre (figura a mio avviso tutt’altro che positiva o amicale) si trova su di un aereo che invece di lasciarlo a Venezia insieme agli altri passeggeri, lascia tutti in un deserto dove riprende la battaglia di “statue”, i passeggeri con lui sono come sonnambuli, consci e assoggettati al loro inevitabile destino, dormienti nel senso più ampio della parola, o messi a dormire, il protagonista è come se fosse l’unica voce della ragione, del pensiero quantomeno critico, che viene fatto allontanare dalla verità nella quale iniziava ad entrare.Mi fermo qui sia per evitare prolissità, sia perché secondo me questo è un racconto pieno di spunti e “allegorie” della società del tempo e della razza umana e mi piacerebbe che venissero tirate fuori e discusse qui, questo libro seppur piccolo potrebbe tirare fuori una grande discussione
Discutine sul nostro forum.