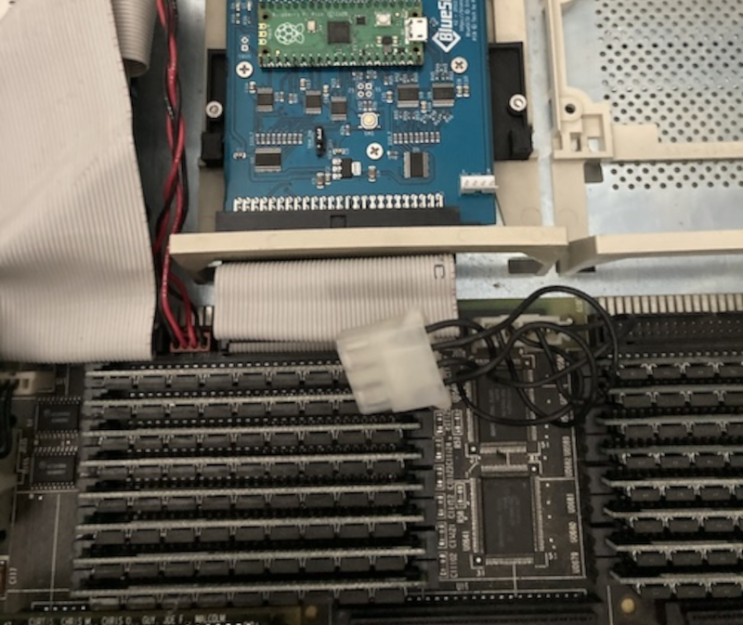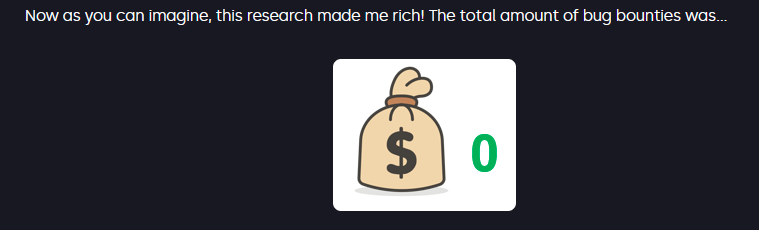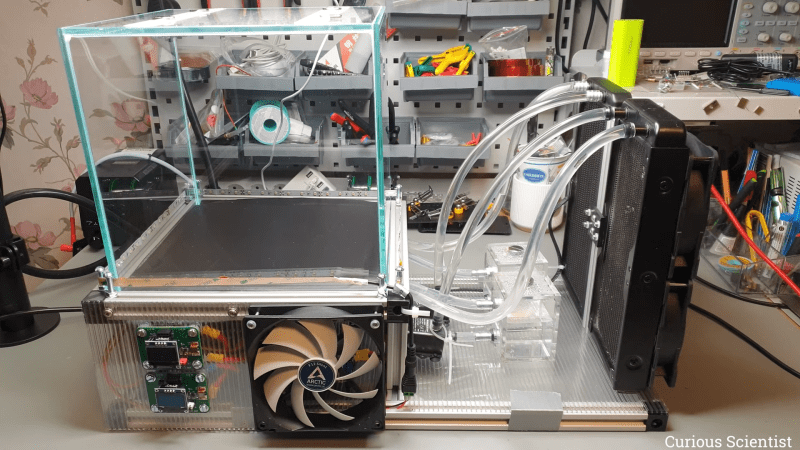Riporto qui di seguito un bellissimo articolo della rivista Micromega.
17 anni senza Solženicyn: l’eredità dello scrittore delle “mani aperte”
Il 3 agosto 2008 ci lasciava lo scrittore che ha portato alla luce le “fognature” del sistema di sterminio sovietico, criticando al contempo un Occidente obnubilato dal consumismo.
“Ci è mancato l’amore della libertà… ci siamo AFFRETTATI a sottometterci, ci siamo sottomessi con PIACERE. Abbiamo semplicemente MERITATO tutto quanto seguì”.
In questa nota a piè di una pagina di Arcipelago Gulag, la monumentale cronaca letteraria della discesa nelle “fognature” del sistema di sterminio sovietico, il premio Nobel Aleksandr Solženicyn enuncia, in poche parole, l’avvio del popolo russo verso il proprio annunciato martirio, enfatizzando, con i caratteri in stampatello, i tre scalini verso l’abisso: la passiva velocità della sottomissione, segnata dal piacere della delega totale, fino alla punizione derivante dalla mancata assunzione di responsabilità.
L’ambìto premio come scrittore gli era stato conferito dall’Accademia svedese nel 1970 “per la forza etica con cui ha portato avanti le tradizioni imprescindibili della letteratura russa”: ben tre anni prima, quindi, della pubblicazione – clandestina, poi diffusa in tutto il mondo – del sopracitato bestseller che porterà il termine “gulag” nel vocabolario dell’uomo comune come simbolo del sopruso, della violenza di Stato studiata e programmata a tavolino con l’intento esplicito di piegare un’intera popolazione al regime del partito unico.
Ma chi entrava nei gulag? Cosa doveva succedere per ritrovarsi in un campo di lavoro forzato dove, chi non resisteva, impazziva, si suicidava o veniva fucilato, mentre i più forti cercavano di conservare i ricordi per raccontare? Bastava poco: una conversazione tra amici ascoltata da orecchie indiscrete, magari da agenti in incognito della Ceka, la polizia segreta sovietica voluta e fondata da Lenin, poco dopo la Rivoluzione d’ottobre del 1917, contro i “nemici del popolo”; un articolo di giornale non perfettamente in linea con i dettami del Partito comunista sovietico; o financo una lettera privata indirizzata a un conoscente: fu questo, esattamente, il capo di imputazione che nel 1945 colse di sorpresa Solženicyn, comunista marxista della prima ora, ufficiale dell’Armata rossa nella Seconda guerra mondiale, infamato dall’accusa di “propaganda e attività antisovietiche” per aver scritto, in quello scambio epistolare, critiche a Stalin, seppur non in chiave anticomunista ma con un focus centrato sulla repressione e sul culto della personalità di cui il dittatore era già oggetto. L’articolo del Codice penale sovietico che consentì la sua condanna a otto anni di gulag, il 58, divenne famoso per la sua eterogeneità ed elasticità di applicazione che consentiva al regime di arrestare, incarcerare e condannare chiunque a pene lunghe, lunghissime e terminali, per un semplice sospetto, una delazione non provata (la “spiomania”, come appellata dallo scrittore), un errore casuale sul lavoro, un furto o una conversazione inquadrabili automaticamente come “reati contro il popolo”. Promulgato nel 1926, l’articolo 58, a cui Solženicyn dedica numerose pagine di Arcipelago Gulag, consisteva in 14 punti, ognuno dedicato a una categoria di reati e sotto-reati. Le pene più blande si aggiravano intorno agli otto-dieci anni, le più severe – comminate anche per reati non gravi ma definiti come perniciosi per l’unità del sistema comunista – arrivavano sino alla fucilazione. I punti decimo e undicesimo, in particolare, vengono raccontati come un capolavoro di capriole burocratico-giudiziarie contro la libertà di pensiero e di opinione: una pena potenzialmente illimitata poteva essere comminata per “propaganda o agitazione contenente un appello all’abbattimento, danneggiamento o affievolimento del potere sovietico […] come pure la diffusione, produzione o custodia di letteratura avente tale contenuto”, laddove per letteratura si lasciava intendere anche uno scritto di un diario personale o uno scambio epistolare tra due persone – come nel caso del nostro protagonista -, numero di individui sufficiente a definire una presunta “organizzazione” contro il Soviet. Ma il capolavoro geo-giudiziario dell’articolo 58 era senz’altro il punto secondo: la “rivolta armata, o la presa del potere nei grandi e nei piccoli centri […] allo scopo di separare con la violenza qualche parte dell’Unione delle repubbliche”, portava alla fucilazione immediata. Con questi criteri, ad esempio, viene processata, all’inizio del 1930, l’intera Alleanza per la liberazione dell’Ucraina, tanto per definire in termini temporali le radici di un conflitto che ancora oggi è sotto i nostri occhi. Se Mosca interveniva, i nazionalisti separatisti estoni, lettoni, lituani, turkestani e ucraini erano candidati immediati a pene minime detentive dai dieci ai venticinque anni.
“Chi oggi non canta con noi è contro di noi”, recitano i versi del poeta rivoluzionario Majakovskij, ironicamente citato da Solženicyn come esempio di strumentalizzazione, in chiave repressiva e censoria, esercitata dalle varie estrinsecazioni del potere sovietico.
In questa cornice, come fu possibile che un ex internato dei gulag, quale era il nostro protagonista, uscito da quella prigione nel 1953 (“grazie prigione per essere stata nella mia vita”), potesse pubblicare, nel 1962, il suo primo racconto, Una giornata di Ivan Denisovič, se proprio in quelle pagine si metteva nero su bianco la vita di un prigioniero che sopravvive a un lager?
L’evento che aveva creato uno spazio consono era stata la morte di Stalin, avvenuta proprio nel 1953, a cui era succeduto Nikita Chruščëv, responsabile di una parziale apertura riformistica che portò, a seguito del disvelamento progressivo dei crimini commessi dal dittatore suo predecessore, a un sottile e fragilissimo disgelo politico-ideologico. Fu in questa finestra che riuscì a incunearsi Solženicyn, cercando di liberare l’arte letteraria, con il contributo di altri mirabili scrittori e poeti come Evgenij Evtušenko, dalle catene del cosiddetto “realismo socialista”, metodo letterario “ufficiale” imposto da Stalin: in conformità a esso, i racconti non dovevano narrare la realtà per ciò che essa era ma piuttosto per ciò che avrebbe dovuto essere, nel compimento di una funzione-missione pedagogica attribuita allo scrittore, nella veste di soldato di penna del regime comunista. Tale appiattimento letterario nella terra che aveva dato i natali ai maggiori scrittori del globo, da Tolstoj a Dostoevskij, viene descritto causticamente da una delle penne-vittima più abili e ironiche degli anni Cinquanta-Sessanta, Andrej Sinjavskij, nel cui pamphlet Che cos’è il realismo socialista?, che gli costerà una condanna pesante a sette anni di gulag, è riportata, nell’introduzione all’edizione italiana, la frase socratica che egli pronunciò alla lettura della sua condanna: “Sono stato accusato di avere scritto che ai tempi di Stalin esistevano campi di deportazione. Ma ditemi, di grazia: dove sarò condotto io stesso quando uscirò da quest’aula?”.
L’ottimismo ideologico sfrenato del realismo socialista imposto dal regime nell’atto di una continua “profilassi sociale” – un ottimismo direzionato allo “Scopo” unico, come denominato da Sinjavskij, sulla cui strada non importava più contare quanti fossero i caduti – conosce quindi un leggero rallentamento nell’era riformistica di Chruščëv: cambia nome in “volontarismo letterario etico”, a indicare una tendenza a rinnovare la società anche attraverso la coscienza critica degli scrittori. Nel breve lasso temporale di tale parziale rinnovamento si inserisce quindi la pubblicazione di Ivan Denisovič nel 1962, autorizzata dallo stesso Chruščëv in persona (leggenda vuole che, tergendosi una lacrima, il leader fosse rimasto colpito da come il protagonista, vessato dalla prigionia, non perdesse mai di vista il lavoro nel campo, unica forma di sollievo dalla tortura quotidiana). Ma non ci si lasci ingannare dalle iniziali aperture kruscioviane, seguite al XX Congresso del Pcus nel 1956, in conseguenza del quale il mondo venne a conoscenza delle purghe, delle persecuzioni, delle carestie artificiali (l’Holodomor in Ucraina, tra il 1932 e il 1933, provocò più di cinque milioni di vittime) e dei gulag voluti da Stalin. Chruščëv, difatti, usò ciò che gli serviva – letteratura inclusa – più per egolatria che per reale convincimento, facendo quasi subito marcia indietro quando, temendo che la situazione gli sfuggisse di mano, determinò che il volontarismo letterario dovesse essere pesantemente limitato e circoscritto al periodo staliniano più come denuncia morale rivolta al passato che come critica politico-ideologica verso il presente.